Gentile Fabio
Sull'argomento in questione le ho già condiviso il mio pensiero. Nei testi antichi i numeri sono utilizzati spesso e volentieri come simboli, e ci si riferiva anche a fenomeni astronomici, ma non nel senso di misurazioni sofisticate come noi oggi le intendiamo, quanto alle osservazioni più evidenti in assenza di strumentazioni, come i cicli del sole, della luna e dei corpi celesti visibili ad occhio nudo. Non esiste nessuna evidenza, neppure lontanissima, che popolazioni umane del paleolitico o magari del neolitico potessero conoscere la precessione degli equinozi, che di certo era nota nel II secolo a.c. ai tempi di Ipparco, e magari si può pure ipotizzare che fosse stata notata già da qualcuno qualche secolo prima, ma non certo al tempo in cui furono scritti i Veda o addirittura i Testi delle Piramidi. Inoltre la questione è completamente irrilevante ai fini della comprensione dei testi antichi, che come le ho detto avevano la funzione di indagare il mondo di "dentro" e non quello di "fuori", in quanto appare evidentissimo dalla lettura di questi testi antichi che non viene descritto lo spazio-tempo di cui abbiamo nozione noi moderni, ma uno spazio-tempo psicologico, che può essere compreso solo abbandonando il punto di vista scientifico.
I testi antichi non parlano di un Universo oggettivo, misurabile sperimentalmente in modo "ripetibile", ma di un Universo psicologico, sperimentabile con la psiche in modo soggettivo.
Spero di aver chiarito il mio punto di vista.
Un caro saluto.
Domenico Rosaci

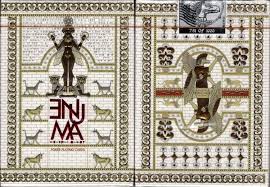
Ciao Fabio, secondo te, perché è stata scritta la Bibbia?
RispondiEliminaMica l'ha scritta una persona, ma forse tutte avevano la medesima intenzione: scrivere qualcosa di vero! Si guardarono bene dal fare una cronaca degli avvenimenti, evidentemente. Il vero e la conoscenza che ad esso porta non si riduce alle cose percepibili solo con i sensi, a ciò che è conscio, razionale. Di questo fatto sono abbastanza sicuro. Ma tutti i testi sacri debbono essere stati scritti con le medesime intenzioni.
RispondiEliminaBuongiorno Fabio, secondo lei quale è la ragione per cui l’effettiva e ‘giusta’ interpretazione dei testi sacri non è giunta nè percepita ai giorni nostri? Vi potrebbe essere stata un’intenzione nel corso dei tempi di tramutare i testi sacri in una sorta di meccanismo di controllo sociale?
RispondiEliminaLa saga dell' Anello di Tolkien, evidente plagio del mito di Gige (Platone), ci dice che questi aspetti della psiche umana erano ben conosciuti nell'antichità e i cd saggi erano coloro che capivano questa vocazione dell'animo umano cercavano di padroneggiarli con la ricerca della Verità, o della conoscenza profonda. I vangeli (Tutti e non solo quelli canonici) credo avessero espresso, come tanti testi sacri di altre culture, i principi sacri a cui ci si doveva attenere, come comunità, per non cadere in questo pericoloso degrado spirituale. Ora taccio e attendo repliche
RispondiEliminaLa sua riflessione sull’aggettivo “giusta” mi pare centrale, soprattutto nel contesto dell’interpretazione di testi sacri come la Bibbia. La distinzione che propone tra interpretazione e decriptazione è particolarmente interessante. Concordo sul fatto che, quando le cifre bibliche corrispondono con precisione a misure cosmiche o cicli astronomici, ci troviamo di fronte a una “decriptazione” più che a una semplice interpretazione. In questi casi, la verifica oggettiva dà forza all’idea che il testo contenga un significato intrinseco e universale, radicato nella realtà del creato.
RispondiEliminaD’altra parte, quando si tratta di testi alfabetici e simbolici, il discorso cambia. Qui l’interpretazione diventa inevitabilmente più soggettiva e dipendente dal contesto storico, culturale e spirituale. In questi casi, credo che una “giusta” interpretazione sia quella che tiene conto della complessità del messaggio biblico, cercando di cogliere non solo il significato letterale, ma anche quello teologico e simbolico.
credo che la giusta interpretazione dunque debba essere guidata da un approccio che contempli tre livelli: il senso letterale (il testo nel suo contesto storico), il senso allegorico (il messaggio spirituale) e il senso anagogico (il suo significato in relazione al fine ultimo dell’uomo e della creazione). Solo integrando questi livelli possiamo avvicinarci a una comprensione più profonda del messaggio biblico.
Gent. Anonimo, sul significato dell'aggettivo 'giusto' stiamo tentando delle definizioni che, se da una parte, sembrano inesorabilmente vincolate ad un eludibile carattere di soggettività, dall'altra reclamano una qualche forma di condivisibilità dalla quale partire per cercare di rendere comprensibile un testo altrimenti oggetto di speculazioni e quindi del tutto privo di interesse in rapporto al percorso di conoscenza che noi tutti cerchiamo di intraprendere.
RispondiEliminaMesso da parte il discorso sui numeri, cercherei adesso col suo aiuto di penetrare a fondo i criteri da lei posti, nel tentativo di avvicinarci quanto più possibile a un'analisi costruita su categorie, non tanto condivisibili/applicabili da noi, persone di questa epoca, ma più che altro cercando di cogliere quale fosse la più corretta maniera di intendere i testi per gli uomini che vivevano tanti anni fa. Questa, perlomeno, mi è parsa l'ambizione del prof. Rosaci, al quale abbiamo dedicato le nostre discussioni e dalla visione d'insieme del quale non vorrei allontanarmi troppo. Ed allora riprenderei il discorso dalla prospettiva del professore, che è quella di penetrare anzitutto il pensiero arcaico, affinché certi scritti possano davvero essere 'convertiti' in veri insegnamenti degli antichi saggi. Quindi, secondo quanto dici , oggi effettivamente un giusto approccio potrebbe esser dato dalla scansione di tre livelli di lettura, e dalla piena integrazione di un livello nell'altro. Ciò può aiutarci ad un approccio 'moderno, questo è vero, però siamo certi che gli antichi seguissero il medesimo criterio di lettura?
Di ciò non credo di esserne sicuro ed infatti ritengo il prof, Rosaci il miglior riferimento per provare ad intaccare la complessità di questo argomento. Anticipo eventuali domande: quali pensatori del passato ci hanno fornito indicazioni utili per appropriarci del contenuto del testo?
Siamo certi che l'approccio letterale fosse per loro importante come lo è per noi? Possibile che ponessero sullo stesso piano il significato letterale con quello simbolico?
Ma un criterio , quello simbolico - domando - non dovrebbe escludere , o quantomeno porre dei limiti, all'altro criterio, quello letterale ? In altri termini, se si utilizza un criterio simbolico non significa forse che quello letterale andrebbe abbandonato? Se infatti quello letterale col suo valore di cronaca, esprimesse tutto ciò che volevano dirci i grandi autori biblici del passato, a che serviva criptare, allegorizzare e in qualche modo, nascondere i testi? Dante infatti , avendo compreso questo principio, ammoniva:
" Voi che avete gli intelletti sani , cercate il significato che s' asconde sotto il velame de li versi strani. . .
più o meno faceva così.
Gentile Fabio,
RispondiEliminacome lei giustamente suggerisce, non possiamo dare per scontato che gli antichi avessero la medesima struttura mentale o la stessa intenzione di stratificare il significato in modo sistematico, anzi tutt’altro. Penso che il simbolismo fosse un linguaggio integrato nel loro modo di pensare, non un livello separato o subordinato rispetto al significato letterale.
Tuttavia, per quanto il criterio simbolico necessariamente pone dei limiti a quello letterale, non credo che quest’ultimo debba essere necessariamente escluso, ma che piuttosto debba essere inglobato in una visione più ampia. L’allegoria, come modalità comunicativa, non è altro che un mezzo per velare e svelare allo stesso tempo, rivolgendosi a lettori diversi con livelli di comprensione diversi. Questo non implica l’abbandono del significato letterale, ma piuttosto la sua relativizzazione. Ritengo, che il livello letterale può essere letto come “l’involucro” che protegge e nasconde il significato profondo. Dante stesso, nel verso che lei cita – “Voi che avete gli intelletti sani, mirate il senso che s’asconde sotto il velame de li versi strani” – non propone di abbandonare il senso letterale, ma invita a trascenderlo per accedere a un livello più alto di comprensione.
Comunque, secondo lei perché ai giorni nostri viene tramandato il significato piú immediato e letterale dei testi sacri, da cui deriva (a mio parere) una significativa riduzione del numero dei fedeli tra le generazioni piú giovani? In particolare, nonostante vi siano appositi corsi dedicati alla religione nelle varie istituzioni di cultura, non si procede mai ad approcciarsi ai testi in modo da cercare di scorgervi il loro ‘giusto’ significato.
Evidentemente laddove i testi sacri vengano letti come resoconti storici, perdono di credibilità dinanzi a chi è cresciuto in un ambiente dominato dalla scienza.
E la scienza , per l'appunto, invalida quasi in toto l'attendibilità storica del testo letterale, e così, non avendoci trasmesso altro criterio di lettura che non sia quello scientifico, ci obbliga ( in realtà obbliga le ultime e più distratte generazioni,) ad abbandonare il tentativo di comprendere la sacralità dei testi antichi. I nostri vecchi davano piena fiducia ai clerici , ossi ai dotti in circolazione, quelli più a portata di mano. Da ciò sembrerebbe che i nonni fossero similmente ignoranti come i nipoti, ma io non credo che le cose non siano messe così. Almeno i nostri vecchi, con la loro ingenua fiducia, tentavano un approccio spirituale alla vita demandando agli ' 'esperti' di spiritualità il compito di ricerca e di interpretazione. C'è una purezza di fondo in questa ingenuità. Ma oggi non vedo questa purezza d'animo farsi strada fra le menti più fresche e nemmeno in quelle più celebrate. Tornando a noi, alle nostre meditazioni, sposo il paradosso dell'involucro che però invalida in quanto tale, qualsiasi riferimento alla realtà intesa come testimonianza diretta di fatti accaduti. Testimonianza sì, ma come resoconto che rimanda alla individuazione collettiva del significato simbolico. Secondo me con quel '. . . versi strani' Dante invalidava il testo letterale, affermava cioè implicitamente che non si doveva credere a qualcosa che suonava strano già nel suo primo e più immediato significato. Questa posizione la tiene anche Platone quando nel mito della caverna indica la conoscenza più bassa (eikasìa) come un qualcosa che appartiene a menti di soggetti incatenati che confondono ombre di statuette per esseri viventi. Questo errore è un'ammissione di incapacità. Ciò ha un senso entro la dinamica di un percorso di conoscenza, ma se, come stiamo postulando noi, questo primo livello di conoscenza di ferma là, così come se ci si ferma al terzo (Dianoia, è la forma di conoscenza a cui ci siamo fermati come civiltà occidentale)) , ecco che non possiamo ritenerci esseri umani compiuti. Rimaniamo cioè difettosi e finiremo per far implodere il nostro mondo in se stesso, nell'abisso delle nostre contraddizioni, precludendoci la possibilità di un un futuro. Questo diceva PLatone, e con lui tane altre forme e voci della antica saggezza . Ritengo sia questa la salvezza di cui parlano le religioni delle origini attraverso i miti.
RispondiEliminaGrazie Blade per non farci mancare il tuo pistolotto quotidiano
RispondiElimina